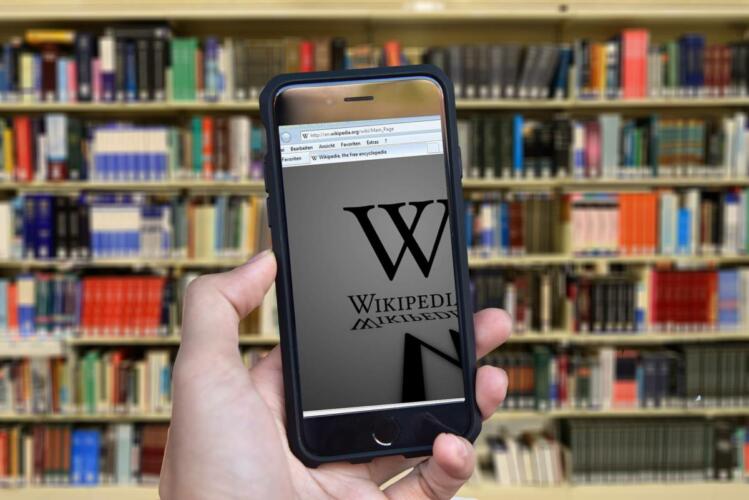Ciao a tutti, oggi parleremo di un argomento molto interessante e importante per la sicurezza online: l’OTP. Ma cos’è esattamente un OTP? Tranquilli, adesso vi spiego tutto!
L’OTP, acronimo di “One-Time Password” (password monouso), è una password generata in modo casuale che può essere utilizzata solo una volta. Questa particolare tecnologia di autenticazione è molto diffusa e viene impiegata in diversi contesti, come la validazione delle firme digitali e la conferma dei pagamenti online.
L’OTP può essere generato attraverso diverse modalità: può essere inviato al nostro smartphone tramite SMS, può essere generato da un’applicazione dedicata sul nostro dispositivo o può essere fornito da un dispositivo hardware specifico. In ogni caso, l’importante è che sia un codice unico, utilizzabile solo per quel determinato scopo e per un breve periodo di tempo.
Quindi, ricapitolando, un OTP è una password temporanea e monouso che ci permette di autenticarci e confermare operazioni online in modo sicuro e affidabile. Grazie a questa tecnologia, possiamo proteggere le nostre transazioni e avere la certezza che solo noi stessi abbiamo accesso ai nostri account e ai nostri pagamenti.
Definizione OTP
Un token di accesso monouso (OTP) è una sequenza di caratteri casuale generata istantaneamente, che ha validità solamente per un’unica occasione. Questo concetto rappresenta l’essenza di questa specifica tecnologia di autenticazione, ampiamente impiegata sia per autenticare firme digitali che per verificare pagamenti online. Grazie all’OTP, per esempio, è possibile convalidare un pagamento avendo la piena certezza che l’operazione è stata effettuata personalmente da noi stessi.
Funzionamento OTP
Solitamente, quando si tratta di operazioni “sensibili” o riservate, come l’accesso a un sito web, il livello base di protezione prevede l’utilizzo di un username/email e una password. Tuttavia, questo livello di sicurezza si rivela spesso insufficiente per proteggere le operazioni di banking online e può essere facilmente aggirato da truffatori se, ad esempio, username e password vengono trafugati e resi pubblici in seguito a falle di sicurezza che rendono disponibili in massa le credenziali su forum di hacker.
Per fortuna, esiste un valido strumento per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza alle tradizionali operazioni di accesso: il token OTP. Questo token è particolarmente utile quando si tratta di operazioni di login legate a username e password statiche, che possono essere vulnerabili ad attacchi informatici come l’utilizzo di dizionari di password (in cui vengono testate simultaneamente molteplici combinazioni di password) o attacchi di replica (quando la stessa password viene riutilizzata su più account).
L’OTP offre una protezione aggiuntiva in quanto, anche nel caso in cui un intruso riesca ad intercettare una OTP utilizzata per accedere a un servizio o effettuare una transazione, non sarà in grado di riutilizzarla nuovamente. Questo rappresenta una delle due caratteristiche principali di un codice OTP affidabile: deve essere generato in modo imprevedibile o addirittura impossibile da prevedere dall’esterno e non può essere riutilizzato.
In conclusione, l’utilizzo di un token OTP offre un livello di sicurezza superiore rispetto alle tradizionali username e password. Questo strumento genera codici difficili da indovinare e impedisce il loro riutilizzo, garantendo così una maggiore protezione nelle operazioni online.
Durata del codice OTP
Una volta che generiamo un accesso via OTP, in pratica generiamo un codice univoco (ad esempio un numero casuale di 6 cifre) che è unico nel suo genere, che non può essere usato su più di un dispositivo e che in genere scade dopo qualche minuto dalla sua generazione. La generazione di codici OTP può avvenire anche mediante app di firma digitale, come avviene nel caso di Namirial ad esempio, che genera un nuovo OTP casuale ogni 30 secondi circa. In questo modo, garantendo la durata limitata di ogni codice, si garantisce una maggiore sicurezza e si limita fortemente la possibilità di abusi.
Come si usa la OTP nella pratica
Le OTP per i pagamenti online sono disponibili sulle carte dei circuiti VISA, Mastercard o American Express, e possono essere utilizzate come fattore di autenticazione aggiuntivo. Ci sono anche OTP per l’accesso a servizi che trattano dati sensibili senza pagamento, e funziona come se fosse una firma digitale.
Con smartphone
Un esempio di accesso con codice OTP e cellulare potrebbe essere:
- andiamo nel sito della nostra banca, e digitiamo username e password del nostro conto
- una volta entrati il sito ci invia un SMS con un codice OTP sullo smartphone che abbiamo registrato
- ricopiamo il codice numerico generato all’interno del sito di home banking della nostra banca, dove indicato;
- confermiamo l’accesso ad avremo ora accesso al conto.
- La stessa procedura può valere anche per effettuare pagamenti online e bonifici, ad esempio, in modo da avere massima probabilità che l’operazione sia stata davvero autorizzata da noi.
Un token è un dispositivo hardware con un display sopra, del tutto simile come design ad un “pennino” USB, ma con funzionalità diversa: serve infatti a generare il codice OTP per il nostro accesso personalizzato. Ognuno di questi dispositivi, quando vengono consegnati, sono univocamente assegnati ad un utente e sono unici nel loro genere, in modo tale che non sia possibile clonarli e che garantiscano l’accesso all’account bancario solo al legittimo proprietario.
Con token
Un esempio di accesso con codice OTP e token potrebbe essere:
- andiamo nel sito della nostra banca, e digitiamo username e password del nostro conto
- su richiesta, generiamo un codice OTP con il dispositivo di cui sopra
- ricopiamo il codice numerico generato all’interno del sito di home banking della nostra banca, dove indicato;
- confermiamo l’accesso ad avremo ora accesso al conto.
- La stessa procedura può valere anche per effettuare pagamenti online e bonifici, ad esempio, in modo da avere massima probabilità che l’operazione sia stata davvero autorizzata da noi.